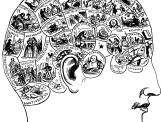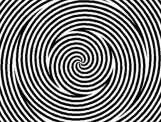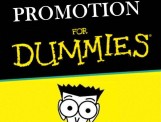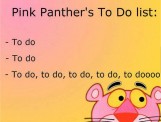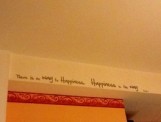20
Feb 2026Elogio dell’opacità
scritto da jadosa / in SENZA FILTRO / Commenta
«L’uomo non è la somma di ciò che ha, ma la totalità di ciò che non ha ancora.» Jean-Paul Sartre
C’era una volta un uomo che voleva conoscere se stesso fino all’ultima cellula. Indossava al polso un sensore, compilava un diario digitale di ogni pasto, misurava il sonno con la precisione di un orologiaio svizzero.
Credeva – come molti, quando il Quantified Self sventolò la sua bandiera – che i dati fossero la strada verso la libertà.
Credeva che misurare significasse capire.
Credeva che capire significasse guarire.
Aveva torto.
Non ottenne padronanza di sé, ma qualcosa di più sottile e inquietante: un sostituto di sé.
Una dashboard al posto dell’anima. Un log di sistema là dove un tempo viveva una storia.
La società di vetro
Immagina una città costruita interamente di vetro. È bellissima: la luce la attraversa da ogni lato, non esistono angoli bui, e nessun segreto sopravvive al sole.
Sembra il trionfo della trasparenza, un ideale fatto architettura.
Ma il vetro non trattiene il calore. Non assorbe. Riflette soltanto.
È lì che viviamo.
Il sociologo Byung-Chul Han, in La società della trasparenza, lo dice lucidità clinica: la trasparenza totale non è libertà, è violenza. «Una società senza segreto», scrive, «è una società senza intimità, e una società senza intimità è una società senza soggetto.»
L’individuo, privato del diritto al mistero, non diventa più autentico: diventa bidimensionale. Una superficie che riflette il mondo senza mai assorbirlo, senza mai lasciare che qualcosa si depositi, sedimenti, trasformi in esperienza.
La fisica stessa ce lo insegna: quello che riflette tutto non trattiene nulla. Così l’essere umano che espone ogni cosa non sviluppa interiorità.
Il paradosso più crudele del tracciamento totale è questo: ci fa credere che l’io sia la somma dei suoi dati.
Ma il Sé, se esiste, se ha mai avuto un indirizzo, non abita nei numeri, abita nel silenzio tra una parola e l’altra, nelle sfumature che nessun algoritmo sa codificare.
Il neuroscienziato Antonio Damasio, in L’errore di Cartesio, ha mostrato l’essenziale: le emozioni non disturbano la ragione, la fondano. L’identità nasce da stati somatici, memorie corporee, quella nebbia di sensazioni che precede ogni pensiero. Ridurre tutto questo a una dashboard significa amputare l’umano proprio nel punto in cui è più vivo.
E tuttavia lo facciamo. Convertiamo la tristezza in sleep score, l’ansia in heart rate variability, la gioia in step count.
Trasformiamo qualità in quantità. In quel gesto perdiamo qualcosa che non sapremo più nominare, perché era precisamente la parte che resisteva al nome.
Il tempo senza storia
Esistono due modi di abitare il tempo.
Nel primo, i momenti sono legati da un senso: una narrazione. Il passato non è un archivio, ma un maestro; il futuro non è un’incognita, ma un orizzonte.
Nel secondo – il tempo della società del dato – gli eventi non sono collegati: sono uno dopo l’altro, non uno accanto all’altro.
Una sequenza di istanti senza storia: un log di sistema.
È il tempo del database, non della memoria.
Lo psicologo Jerome Bruner lo ha detto con chiarezza: la mente umana è narrativa. «Noi non percepiamo il mondo,» scriveva, «lo raccontiamo.» La narrazione non è un lusso: è l’ingranaggio che dà coerenza al sé. Senza di essa, restano solo KPI esistenziali aggiornati in tempo reale. Un essere umano ridotto a software in esecuzione.
Raccontare è guarire
Ed è qui, in questo deserto di dati, che la parola si fa medicina. Il trauma, insegna la clinica psicoanalitica da Freud a Bessel van der Kolk, non è un ricordo: è un ricordo non narrato.
Un evento che il cervello non ha saputo integrare nel flusso della storia personale, rimasto congelato, frammentato, isolato. Il lavoro terapeutico consiste quasi sempre nel restituire narrazione a ciò che era rimasto muto. Nel dare forma all’informe, nel trasformare il trauma da dato in capitolo di una storia più grande.
Van der Kolk, nel suo Il corpo accusa il colpo, lo sintetizza così: «Per guarire dobbiamo essere in grado di raccontare la nostra storia.»
Ma raccontare non è spiegare tutto. La narrazione che cura abita il segreto, accetta l’indicibile, lascia spazio al buio come parte fertile dell’esperienza.
La narrazione curativa non è una cronaca trasparente, è qualcosa di molto più ambiguo e necessario: un atto che abita il segreto, che lascia spazio all’indicibile, che accetta il buio non come difetto da correggere ma come metafora fertile dell’ignoto.
La letteratura lo sa da sempre. La scienza lo sta imparando.
Gli studi dello psicologo James Pennebaker hanno dimostrato con rigore sperimentale che scrivere di esperienze dolorose migliora la salute immunitaria, riduce i sintomi depressivi e rafforza la resilienza (ne ho parlato anche io nel mio Scrivere fa bene). Ma il punto decisivo è uno: gli effetti benefici si manifestano solo quando la scrittura è narrativa, non descrittiva.
Solo quando chi scrive costruisce un senso, non quando elenca fatti.
Il dato nudo non guarisce. La storia sì.
Pensare è narrare
La società dei metadati diffida della teoria. La teoria è lenta, ambigua, refrattaria alla misura: tutto ciò che l’algoritmo non tollera.
Eppure la teoria è una narrazione sul mondo. Uno sforzo per dare forma al caos, per decidere cosa illuminare e cosa lasciare nell’ombra.
Paul Ricoeur lo ha dimostrato: pensiero e narrazione sono la stessa cosa sotto nomi diversi. «Il tempo,» scriveva, «diventa tempo umano quando è articolato narrativamente.»
Non esiste comprensione senza trama. E ogni trama implica una scelta: un’ombra necessaria.
Quando smettiamo di raccontarci per limitarci a tracciarci, non diventiamo più oggettivi. Diventiamo più vuoti.
Rinunciando all’ombra, perdiamo anche la luce.
Scegliere l’opacità, oggi, è un atto di resistenza contro la dittatura del visibile, contro l’imperialismo del dato, contro la religione laica della trasparenza che promette salvezza e consegna una prigione di cristallo.
È recuperare la narrazione come medicina: non la cronaca, non il report, ma la storia.
È riconoscere il Sé come qualità viva, che nasce nel non detto e muore quando viene esposto in eccesso.
È accogliere l’ignoto non come assenza, ma come condizione per la fantasia, la creatività, la salute mentale.
La nebbia non cancella il mondo: lo restituisce al suo enigma.E solo tornando a essere un mistero per noi stessi smetteremo di essere lastre di vetro trasparenti e fragili, e torneremo a ciò che siamo sempre stati: esseri umani.
Profondi, qualitativi, narrativi.
Opachi.